Verrebbe da dire “peccato, un’occasione mancata”, e che il nostro Paese alla fine non è si è fatto trovare pronto. I numeri lasciano del resto spazio a poche interpretazioni: in Italia la media dello smart working è ferma al 13,6 per cento, contro quella dell’Unione europea che è superiore di sette punti percentuali, con punte che arrivano al 25 per cento della Germania e ad oltre il 30 della Francia.
Il dibattito si aperto nei giorni scorsi con la notizia della mancata proroga per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni: una scelta del governo – adottata nonostante il tentativo contrario del ministro del Lavoro Andrea Orlando – che è in realtà la spia di un approccio che non è esagerato definire generalizzato, ovvero quello di considerare il lavoro a distanza un costo o al massimo una nuova variabile del welfare. Lo stesso esecutivo aveva del resto scelto attraverso il ministro Renato Brunetta di tornare rapidamente a considerare per la pubblica amministrazione la modalità “in presenza” come quella normale. Il protocollo di regolamentazione firmato nel dicembre scorso con le parti sociali non è stato quindi l’auspicato, per noi, primo passo in un percorso generale di modernizzazione.
Un peccato, si diceva, perché lo spazio aperto dalla pandemia avrebbe potuto essere valorizzato con maggiore fiducia (vale anche per i privati, anche se in questo caso la lungimiranza è stata maggiore) e attraverso interventi normativi più profondi, in grado di rendere lo “smart working” veramente tale e non semplicemente e limitatamente una modalità emergenziale di lavoro a distanza. Si sarebbe potuto agire, ad esempio, sul versante dei diritti, si sarebbero potute differenziare e regolamentare le diverse tipologie. Prevale a quanto pare, e non solo nei decisori, l’idea dello smart worker come un rischio e dello smart working come strada per lavorare di meno.
Accompagnare invece un cambiamento culturale e di mentalità potrebbe essere di beneficio e dare un’opzione in più per il rilancio e per il contrasto dello spopolamento anche in tante aree interne, oltre che costituire un valido pilastro per la realizzazione di strategie di organizzazione urbana e territoriale in grado di valorizzare la prossimità piuttosto che gli spostamenti di massa. Lo schema, giustamente visto come un modello, della cosiddetta città dei quindici minuti, che annovera tra i suoi benefici principali quelli ambientali.
Rimane la considerazione amara, ma speriamo non definitiva, di un Paese che spesso e volentieri sembra assecondare le spinte conservatrici e pare incapace di puntare sulle aperture e sulle opportunità, se non confinandole in pochi casi – scuola che crescono e prosperano nonostante tutto. Niente è perduto, si intende, in questo come in altri ambiti, e non è detto che in futuro la forza dell’innovazione non riesca a imporsi sollecitando se non altro il buon senso di chi la guarda scetticismo e diffidenza.
Michele Fina
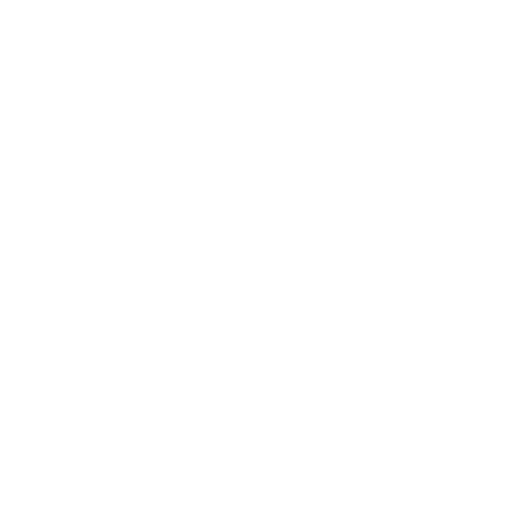





Scrivi un commento